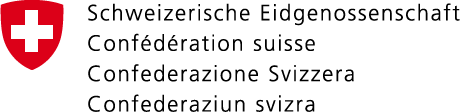Dei 19 milioni di abitanti del Burkina Faso, il 70% ha meno di 35 anni. Di questi, 400’000 giovani arrivano ogni anno sul mercato del lavoro senza possedere qualifiche. Sono dati che parlano chiaro: il Burkina Faso, come molti altri Paesi, deve affrontare sfide molto grandi in materia di formazione e collocamento dei giovani.
La DSC si impegna da vari decenni per migliorare la qualità dell’istruzione di base e della formazione professionale in questo Paese africano. Dal 2016 il Consiglio nazionale dei datori di lavoro del Burkina Faso (CNPB), organizzazione mantello delle aziende del settore privato, agisce a pieno titolo come partner strategico della DSC. L’obiettivo del CNPB è convincere il maggior numero di imprese e artigiani a creare posti di apprendistato nelle loro aziende.
Nella carrozza ristorante di un treno che da Berna porta a Losanna, dove si tiene la Conferenza annuale della cooperazione svizzera allo sviluppo, incontriamo Issa Compaoré, segretario incaricato dell’occupazione e della formazione professionale presso il CNPB, e Ambroise Tapsoba, collaboratore specializzato dell’Ufficio di cooperazione della Svizzera in Burkina Faso.
Qual è il messaggio che volete far passare in Svizzera?
Issa Compaoré (IC): Sono qui per dire che il Consiglio nazionale dei datori di lavoro del Burkina Faso (CNPB) è onorato di poter contare sulla fiducia della DSC nel migliorare le prospettive dei giovani in Burkina Faso; aggiungo anche che siamo determinati a procedere in questa direzione. Il settore privato è chiamato a svolgere un ruolo essenziale per aiutare i giovani a costruire un progetto di vita.
Ambroise Tapsoba (AT): Dal canto suo, la DSC può mostrare che il lavoro in cui si impegna da molti anni ha avuto risvolti concreti sulla vita delle persone. Diversi progetti hanno infatti permesso agli adolescenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di guadagnarsi da vivere e di esercitare a tutti gli effetti la propria cittadinanza. Con la partecipazione del settore privato i nostri sforzi dovrebbero riuscire a massimizzare questo impatto. Abbiamo dovuto convincere il Governo a coinvolgere le aziende nella riforma del settore della formazione professionale, e oggi possiamo dire di avercela fatta.
È difficile immaginare che il settore privato non sia stato chiamato prima in causa come partner della formazione professionale…
AT: Il debole coinvolgimento del settore privato deriva dal fatto che il nostro sistema scolastico è sempre stato concepito per permettere all’amministrazione di assumere dirigenti, non per stimolare l’economia. L’istruzione di base e la formazione professionale non rispondono alla stessa logica. Il nostro Paese ha sempre faticato a integrare nei suoi programmi educativi la dimensione pratica dei mestieri.
IC: È vero che molti insegnanti oppongono una certa resistenza quando qualcun altro contribuisce alla trasmissione del sapere. E poi c’è anche una questione molto più politica che riguarda la separazione dei poteri. Il nostro Stato è sempre stato abituato a essere quello che fa tutto. Diciamo che, da parte dello Stato, c’è una certa lentezza nell’apprendere quella che potremmo chiamare «governance condivisa». E non mi riferisco solo all’esclusione del settore privato: anche le collettività locali e la società civile conoscono queste dinamiche.
In veste di organizzazione mantello di numerose associazioni professionali, come procederete concretamente per coinvolgere le aziende nella formazione professionale?
IC: Andremo di porta in porta, spiegheremo come intendiamo procedere e perché è necessario che avvenga questa svolta. Il nostro obiettivo è individuare 400 imprese disposte ad accogliere apprendisti. Queste riceveranno un’etichetta che le qualificherà come esempi da seguire.
Trovate resistenze in alcune aziende?
IC: È chiaro che formare apprendisti comporta dei costi. Ma come avviene anche in Svizzera, le aziende che possono contare su personale ben formato che soddisfi le loro esigenze possono trarre un notevole beneficio da questi investimenti. Una delle sfide è sensibilizzare le imprese a differenziare gli apprendisti dai tirocinanti non pagati o pagati con un basso salario. Affinché questo accada, però, bisogna adeguare la legislazione in modo da garantire una migliore tutela degli apprendisti.
AT: Prima di istituzionalizzare la formazione professionale bisogna lavorare su altri punti, come la qualità delle formazioni offerte, la pertinenza dei curriculum e le competenze degli stessi formatori. Stiamo collaborando con i ministeri competenti su tutta una serie di nuovi standard.
IC: Sono completamente d’accordo sulla necessità di preparare il terreno. La Svizzera si distingue dagli altri donatori perché attua le sue riforme in modo graduale, ma allo stesso tempo con fermezza. È chiaro che in questa fase non serve aumentare i centri di formazione: la questione prioritaria è innanzitutto trovare le aziende formatrici.
Ponendo che ognuna delle 400 aziende che intendete coinvolgere assuma uno o due apprendisti, in che modo potranno essere assorbiti i 400’000 giovani che ogni anno giungono sul mercato del lavoro?
IC: Intanto è certo che il nostro andamento demografico dovrà subire una flessione. L’istruzione di base, a cui oggi ha accesso l’85% dei bambini burkinabé, apporterà senza dubbio un contributo in tal senso. E poi dobbiamo puntare a trasformare la nostra economia. L’esportazione di oro e cotone non è tutto. La trasformazione dei prodotti agricoli, per esempio, nasconde un potenziale enorme, e lo stesso vale per il terziario. Tutti questi giovani di cui parliamo non restano comunque con le mani in mano; il problema, piuttosto, è la loro scarsa produttività. Se riceveranno un’adeguata formazione, potranno superare la loro condizione di «bomba sociale» e diventare la forza innovatrice del Paese.